Aristotele e Eugène Labiche (II)
Traduction de Annamaria Martinolli
Il presente saggio breve è stato pubblicato il 01 gennaio 1887 sul periodico Revue Bleu: revue politique et littéraire, pp. 243-247. L’autore è il filosofo Paul Janet. La traduzione è a cura di Annamaria Martinolli.
La filosofia di Aristotele a teatro
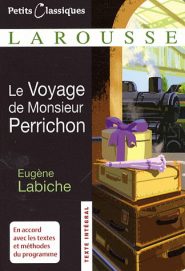 Senza soffermarsi oltre sulle riserve precedenti, vediamo ora come il pensiero del filosofo è stato tradotto in dramma e commedia.
Senza soffermarsi oltre sulle riserve precedenti, vediamo ora come il pensiero del filosofo è stato tradotto in dramma e commedia.
Innanzitutto va sottolineato che, per trasporre un pensiero di questo tipo sul palcoscenico, bisogna passare dalla psicologia alla morale. È infatti impossibile, per un drammaturgo, mantenersi nello stato di indifferenza teorica che caratterizza in modo così originale il passaggio di Aristotele. Una verità puramente speculativa non è drammaturgica. Dire che le cose sono di questa o quella natura significa essere saggi, non poeti o artisti. Il dramma in generale ci interessa solo se mostra quello che è in conflitto con ciò che deve essere. Questo discorso vale anche per il dramma in cui non c’è alcuna lotta tra il dovere e la passione, come ad esempio il dramma antico. Nell’Edipo Re non viene trasgredito alcun dovere, e non vi è nemmeno un dovere da compiere: da cosa derivano, quindi, l’emozione e la pietà che proviamo? Dal fatto che paragoniamo il crudele destino di Edipo con quello che dovrebbe essere in realtà se non si dimostrasse così ingiusto e crudele. Le lacrime nella tragedia, e il riso nella commedia, indicano sempre che le cose non sono come dovrebbero essere.
Il riso
Lasciamo da parte la tragedia, molto lontana dal nostro contesto, e focalizziamoci sulla commedia. L’elogio e la disapprovazione sono nel suo caso fondamentali, mentre l’indifferenza non le appartiene affatto. Perché mai dovrei ridere di quello che è perfettamente conforme alla natura, di quello che trova la sua ragione d’essere proprio nella natura delle cose? Uno Spinoza, che trova spiegazioni per tutto, non ride. Vi è certamente il riso del bambino, che si diverte con i lazzi di Pulcinella, senza alcuna idea morale; e gli adulti, a volte, ridono anch’essi in questo modo: è lo scopo della farsa, dove si ride senza motivo. Per gli uomini questo può rivelarsi anche un utile diversivo, come i giochi di parole dopo cena. Ma il riso comico è di tutt’altro tipo: presuppone sempre una forma di disapprovazione; si applica a ciò che risulta sconveniente, fuori posto, ingiusto, irragionevole; presuppone sempre che le cose non siano quello che dovrebbero essere e, di conseguenza, presuppone la morale. Da questo si intuisce come la commedia sia sempre legata alla morale e la presupponga.
Il comportamento di Labiche
 Per tornare al nostro argomento, Eugène Labiche, dovendo rappresentare l’ingratitudine, non poteva restare freddo e indifferente come Aristotele. Egli non si è quindi limitato a comportarsi da psicologo, ma ha agito anche da satirico e moralista; non ha descritto l’ingratitudine, ma l’ha stigmatizzata, e per farlo ha utilizzato l’arma che la sua stessa arte gli ha messo a disposizione: il riso.
Per tornare al nostro argomento, Eugène Labiche, dovendo rappresentare l’ingratitudine, non poteva restare freddo e indifferente come Aristotele. Egli non si è quindi limitato a comportarsi da psicologo, ma ha agito anche da satirico e moralista; non ha descritto l’ingratitudine, ma l’ha stigmatizzata, e per farlo ha utilizzato l’arma che la sua stessa arte gli ha messo a disposizione: il riso.
Qui si presenta un nuovo scoglio da superare. Affinché la commedia faccia ridere, bisogna che le peripezie da essa annunciate non siano eccessivamente odiose; perché se così fosse, non susciterebbero più il riso ma l’indignazione, e la commedia virerebbe al dramma. Se la commedia ritrae dei personaggi odiosi, come a volte accade, lo fa lasciando da parte quello che hanno di odioso ed evidenziando solo il loro lato ridicolo. Un comportamento di questo tipo trova piena giustificazione nel fatto che non si può sempre mantenere un tono indignato al cospetto degli altri: è un atteggiamento violento che non può e non deve persistere. È questo il motivo che ci spinge, spesso, a limitarci a un sorriso quando disapproviamo un’azione molto cattiva. La commedia agisce allo stesso modo: se ritrae l’avaro, non ne ritrarrà mai, come Balzac, lo spaventoso egoismo; piuttosto ne ritrarrà la mediocrità e l’assurdità.
I vizi
Esistono dei vizi che non si prestano affatto a essere trattati in maniera scherzosa. L’egoismo, ad esempio, è uno di questi: nessuno è ancora riuscito a realizzare una commedia sull’argomento; e anche Labiche ha fallito. L’ipocrisia, nonostante il genio di Molière, non ha affatto assunto i contorni dello scherzo; Tartufo è odioso, ma non è mai divertente; ragion per cui Il Tartufo è più un dramma che una commedia. Molière ha tuttavia trovato il modo di inserire nel testo un po’ di allegria, ma solo nei ritratti delle vittime del protagonista. È da lui che si sprigionano quei tratti da commedia che rallegrano la pièce; ma illuminano gli altri personaggi e non Tartufo, che resta cupo e ripugnante.
L’ingratitudine rientra tra i vizi più insopportabili che meno si prestano allo scherzo. Essa viene vista come qualcosa di ripugnante; rappresenta una bassezza e una mancanza di cuore che suscitano disprezzo e non ilarità. Così, alla pari dell’egoismo, essa non ha ispirato nessuno dei nostri autori comici. È probabile che ci siano stati numerosi tentativi di ritrarre questo difetto, ma senza alcun successo. Infatti, non conosciamo nessuna commedia famosa che tratti una simile tematica. È quindi un onore, per Eugène Labiche, aver risolto questo problema. Ma la domanda è: come ha fatto?
Il viaggio del Signor Perrichon
 Qualcuno sostiene che l’autore non avesse affatto pensato, in origine, all’idea morale che si ricava dal suo testo. Voleva semplicemente realizzare una pochade, com’era sua abitudine, e ritrarre le ridicolaggini di un borghese parigino che, per la prima volta in vita sua, intraprende un viaggio. È la stessa idea che sta alla base del Voyage à Dieppe, di Alexis Wafflard e Joseph Fulgence, e la cui tematica può essere ripresa modificando le circostanze, e in un tono molto piccante, con elementi di realismo che il nostro teatro oggi ammette liberamente e che un tempo non avrebbe osato utilizzare. Il primo argomento è ben evidente nel primo atto, molto divertente, del Viaggio del Signor Perrichon, che tuttavia limita la sua comicità a una serie di incidenti legati alla partenza del personaggio dalla stazione. Solo in seguito, nello sviluppo dell’azione, l’autore arriverà alla tesi filosofica della pièce.
Qualcuno sostiene che l’autore non avesse affatto pensato, in origine, all’idea morale che si ricava dal suo testo. Voleva semplicemente realizzare una pochade, com’era sua abitudine, e ritrarre le ridicolaggini di un borghese parigino che, per la prima volta in vita sua, intraprende un viaggio. È la stessa idea che sta alla base del Voyage à Dieppe, di Alexis Wafflard e Joseph Fulgence, e la cui tematica può essere ripresa modificando le circostanze, e in un tono molto piccante, con elementi di realismo che il nostro teatro oggi ammette liberamente e che un tempo non avrebbe osato utilizzare. Il primo argomento è ben evidente nel primo atto, molto divertente, del Viaggio del Signor Perrichon, che tuttavia limita la sua comicità a una serie di incidenti legati alla partenza del personaggio dalla stazione. Solo in seguito, nello sviluppo dell’azione, l’autore arriverà alla tesi filosofica della pièce.
Per chiarire ogni dubbio riguardo alla casualità con cui Labiche avrebbe trovato l’idea generale che attualmente costituisce il culmine della sua pièce, siamo andati a parlare con lui. Ci ha risposto di essere effettivamente partito da un’idea generale e che per lui la commedia era il risultato della semplice applicazione, e successivo sviluppo, di quest’idea.
In qualunque modo sia nata la cosa, il contesto animato, borghese e familiare in cui si svolge l’azione predispone l’animo all’allegria e induce lo spettatore a prendere come uno scherzo una serie di peripezie che, se ritratte in modo serio, avrebbero suscitato ripugnanza.
La seconda circostanza che favorisce l’effetto comico della pièce è il fatto che l’eroe, sempre che si possa utilizzare questo termine, è un semplicione, composto di atomi borghesi, chiuso a qualsiasi forma di gentilezza e, al contrario, ben aperto ai calcoli grossolani di un egoismo inconsapevole. Molière ha ritratto spesso figure di questo tipo nei suoi Sganarello, Gorgibus o Argante. Sono l’ingenuità e la banalità del vizio a rendere comico il personaggio. Ragion per cui, uno strappo alla regola della castità – argomento che, per alcune classi sociali, è serio e tragico – finisce per suscitare il sorriso delle soubrette e delle contadine che non ci vedono alcuna malizia perché ignorano ancora come vanno le cose.
Queste sono le precauzioni generali prese dall’autore per predisporre lo spettatore al riso in un ambito che sarebbe più adatto a suscitare tristezza.
Labiche e Aristotele
 La vera scoperta, però, è stata proprio l’idea, da noi individuata in Aristotele, che ha costituito il fulcro della pièce. Labiche ha intuito che non si trattava solo di un’idea psicologica, ma di un’idea drammaturgica che poteva facilmente convertirsi in idea comica. Quest’idea è drammaturgica in quanto fornisce un’antitesi rappresentabile; ed è comica in quanto tale antitesi, sviluppata in un unico e medesimo personaggio, contiene una sorta di contraddizione che, come si è spesso dimostrato, costituisce uno degli elementi fondamentali del riso. Se avessimo messo faccia a faccia un uomo ingrato verso il suo benefattore e un uomo debole verso il suo protetto, non sarebbe stato possibile attenuare l’odiosità del comportamento del primo e nemmeno condannare l’atteggiamento del secondo, perché amare coloro ai quali facciamo del bene è considerato più che legittimo. Ma scegliere di far passare lo stesso personaggio – il borghese mediocre e ingenuo di cui abbiamo parlato – per le due fasi successive ci dà la possibilità di rendere la prima situazione sopportabile e la seconda ridicola. Il primo atteggiamento, pur mantenendo la sua bassezza, diventa scusabile, poiché il beneficato, trasformatosi in benefattore, è tentato, senza rendersene conto e in base alla legge di Aristotele, di dimenticare il suo primo benefattore. Da salvato diventa salvatore: come si può pensare che questa situazione, così nuova per lui, non lo inebri? Allo stesso tempo, però, questa ebbrezza così naturale e perdonabile diventa ridicola, perché è solo la maschera dell’ingratitudine.
La vera scoperta, però, è stata proprio l’idea, da noi individuata in Aristotele, che ha costituito il fulcro della pièce. Labiche ha intuito che non si trattava solo di un’idea psicologica, ma di un’idea drammaturgica che poteva facilmente convertirsi in idea comica. Quest’idea è drammaturgica in quanto fornisce un’antitesi rappresentabile; ed è comica in quanto tale antitesi, sviluppata in un unico e medesimo personaggio, contiene una sorta di contraddizione che, come si è spesso dimostrato, costituisce uno degli elementi fondamentali del riso. Se avessimo messo faccia a faccia un uomo ingrato verso il suo benefattore e un uomo debole verso il suo protetto, non sarebbe stato possibile attenuare l’odiosità del comportamento del primo e nemmeno condannare l’atteggiamento del secondo, perché amare coloro ai quali facciamo del bene è considerato più che legittimo. Ma scegliere di far passare lo stesso personaggio – il borghese mediocre e ingenuo di cui abbiamo parlato – per le due fasi successive ci dà la possibilità di rendere la prima situazione sopportabile e la seconda ridicola. Il primo atteggiamento, pur mantenendo la sua bassezza, diventa scusabile, poiché il beneficato, trasformatosi in benefattore, è tentato, senza rendersene conto e in base alla legge di Aristotele, di dimenticare il suo primo benefattore. Da salvato diventa salvatore: come si può pensare che questa situazione, così nuova per lui, non lo inebri? Allo stesso tempo, però, questa ebbrezza così naturale e perdonabile diventa ridicola, perché è solo la maschera dell’ingratitudine.
Tuttavia, c’è dell’altro: perché l’ingrato si converta in uomo ridicolo e venga davvero punito, deve subire un inganno ed essere un falso salvatore, e colui che lo inganna deve essere un Machiavelli da banco, poiché il fulcro dell’azione consiste in questo. Poi bisogna che ci siano due innamorati, in concorrenza leale tra loro: il primo, felice e coraggioso salvatore del padre della sua amata, che si era cacciato in un pericolo reale; il secondo, abbastanza furbo da farsi salvare da un pericolo inesistente.
Infine, affinché la pièce sia una commedia e non un dramma, bisogna, nell’interesse dello spettatore che vuole sentirsi felice uscendo da teatro, che l’amore onesto venga ricompensato, che l’amore falso venga punito e che il semplicione raggirato si renda conto della sua stupidità giurando, un po’ tardi, di non cascarci più.
Sono queste le sottigliezze psicologiche che costituiscono la solida base di una commedia la cui gaiezza dissimula così abilmente la profondità.
Conclusioni
A conclusione di questo breve studio di psicologia drammaturgica, vale la pena riportare le parole dell’autore della commedia che, nel ringraziarci per la pagina di Aristotele che gli abbiamo indirizzato, ci ha risposto: “È un collaboratore di cui vado molto fiero, e che non mi aspettavo proprio”. A questo punto, quando Il viaggio del Signor Perrichon andrà di nuovo in scena, bisognerà aggiungere sul manifesto: “di Aristotele e Eugène Labiche”. Aristotele, infatti, non è più, come nel caso di Molière, solo un’autorità piacevole citata da Sganarello o da Vadius, ma diventa egli stesso autore della commedia.

 Aristotele e Eugène Labiche (I)
Aristotele e Eugène Labiche (I)